Elisa Emiliani e Nicoletta Vallorani, in questi lunghi giorni di forzata inattività, hanno costruito un dialogo di domande e risposte, di riflessioni e piccoli racconti che hanno deciso di regalare ai lettori.
Con Zona 42 Elisa Emiliani ha pubblicato lo scorso anno Cenere, una storia di resistenza e amicizia femminile, mentre Nicoletta Vallorani è tornata dopo lunga assenza alla fantascienza con Avrai i miei occhi, storia di una Milano frammentata, di corpi e di cose.

Elisa Emiliani: Comincio da qui: ho notato la tua passione per la parola asincrono. L’ho trovata parecchie volte nel tuo ultimo romanzo, Avrai i miei occhi, e così l’ho cercata su un vecchio dizionario etimologico che non so perché ho comprato, visto che c’è tutto online; comunque ho scoperto che la derivazione è greca, synchronos, contemporaneo o, in questo caso, il suo contrario. Il che sembrerebbe appropriato per una storia di fantascienza, ma asincrono nel tuo romanzo si accosta a una dimensione che definirei esistenziale più che meccanica, sottolineando un’asimmetria che si rifrange su molteplici stratificazioni: quella dei corpi, quella della città, ma soprattutto quella dell’anima della voce narrante e che si riflette nello stile della narrazione.
Allora mi piacerebbe chiederti: quali sono le radici di questa parola e questo concetto, nella tua vita letteraria?
Nicoletta Vallorani: Asincrono, sì, è una bella parola e un bel concetto. Richiama il senso di qualcosa che non torna, che richiama una forma di libertà, la scelta di essere incongruenti, non per gioco ma per impulso conoscitivo. Non voglio far finta di aver meditato la scelta, non mi ero resa conto di usare tanto questo specifico termine in Avrai i miei occhi, ma è plausibile: tutto, in questa storia, parte dai dipinti di Beppe Devalle, che sono figure asincrone e distorte per definizione e per scelta. Visi che si smontano, corpi che confliggono, e nel farlo raccontano storie dolorose ma istruttive. Credo di aver sentito Beppe usare spesso questo termine, e in ogni caso l’ho sempre applicato ai suoi dipinti. E il termine ha una musica che mi richiama ostinazione e libertà, entrambe caratteristiche che mi appartengono, e che contengono per me caratteristiche di irrinunciabilità. E poi c’è la musica delle parole. Io non dipingo e non so cantare, perciò la musica delle parole è tutto quello che ho.
Questo aspetto di stile è tra le prime cose che mi ha colpito di Cenere. Hai già una voce molto precisa. Asciutta ed essenziale, molto congruente con la tipologia di personaggi che scegli. Ci hai ragionato? È stata una scelta? Oppure semplicemente è venuta così? A te la palla, ma belle.
EE: Ho studiato filosofia, all’università, poi semiotica. Non ho mai considerato seriamente di farne un mestiere, anche se amavo molto studiare. Ho sempre pensato che il lavoro per campare e il lavoro dello spirito dovessero essere ben separati, quindi ho fatto la rappresentante di pelletteria, ho lavorato come admin per un distributore di luce e gas in Inghilterra e ora scrivo progetti internazionali. La scrittura è sempre andata in parallelo a tutto ciò, una costante, diciamo!
E venendo ai miei protagonisti adolescenti e al modo in cui li scrivo: è una cosa voluta nella misura in cui mi riesce fastidioso fare altrimenti. Dalla facoltà di filosofia ho preso l’insofferenza nei confronti dei paroloni, e scrivendo mi viene naturale cercare di arrivare all’osso, togliere tutto il possibile. A volte penso di scrivere young adult scarnificati!
E la pittura, le arti visive. È questo il quadro a cui ti riferisci, vero?
Forse nelle arti visive è più evidente che nella scrittura come si possa descrivere una scena con poche pennellate, il naturale evolversi della tecnica, nei secoli come nella carriera di un singolo individuo.
A proposito di evoluzione e di anzianità di settore, come si è modificata e si sta modificando la tua scrittura? In che misura, e in che modo, influiscono ostinazione e libertà in questo processo?
NV: Sono certa di alcune cose, tipo che le parole debbano essere usate con cura, non vadano manomesse, meritino rispetto, perché altrimenti finisce che non svolgono più il proprio ruolo. E poi, per chi scrive, le parole sono Il talento, e nessun talento va usato per se stessi e in solitudine. È questione di consapevolezza, solidarietà, appartenenza. Ho fatto l’insegnante tutta la vita, e alla fine questo mestiere mi definisce. Ed è una cosa che non si fa da soli. Consapevolezza per me è attenzione alla relazione e costante controllo del mio uso delle parole, che servono a me, ma anche alla comunità cui appartengo. Scriviamo per comunicare, almeno alcuni di noi. E quindi, tornando a te: fare un sacco di mestieri nella scrittura serve moltissimo, perché quello è mestiere; non cominci subito a fare arte. Prima impari gli attrezzi e il loro uso, e poi magari…
Sì, il quadro di cui parlo è quello. Le artiste suicide delle quali Beppe continuava a parlarmi, nel capannone che usava da studio, e che era per me una specie di caverna delle meraviglie. L’arte ti cambia lo sguardo, smuove emozioni. È così anche per te? E credi che questo possa essere il modo giusto di reagire anche alla letteratura? A che cosa vuoi arrivare quando scrivi, ti interessa di più il cuore o il cervello?
La mia scrittura è cambiata perché sono cresciuta, e se non cresci meglio che smetti, dato che da vivere lo ricavi da qualcosa d’altro. Io sono una che impara. E sono ostinata. Se non lo fossi stata non mi sarei incaponita a scrivere fantascienza. che è un contesto così unfriendly per le donne. Non impossibile, ma non facile.
EE: Sulla consapevolezza, mi sembra che tu ne abbia un bel po’, che si declina come responsabilità (anche politica, pratica nel senso di morale) nei confronti della comunità. Su questo fronte io sono molto confusa, le mie storie hanno un che di politico perché tutto è politica, ma scrivo per diletto (o per sopravvivenza), per me è una questione ludica e insieme esistenziale. La scrittura ha preso il posto della religione. A proposito di mente, cuore e mete da raggiungere: ho grande stima per la tecnica, direi che è il discrimine, per me, tra un libro riuscito bene e uno riuscito male. La tecnica si può, e si deve, imparare, con l’esperienza o lo studio. Il cuore invece è un’altra cosa, è il motivo per cui un romanzo, o un quadro, o un brano musicale, sono diversi da altri prodotti d’ingegno. Voglio scrivere delle storie belle, provare a metterci dentro qualcosa che ho pensato di capire. Fondamentalmente questo: un esercizio autoconclusivo, forse un po’ zen!
Visto che si parla di consapevolezza, responsabilità, comunità e contesti poco friendly per le donne, vorrei introdurre l’argomento del genere. Ho guardato la presentazione di Avrai i miei occhi al Covo della Ladra e mi sembra che tu abbia detto che la scrittura non ha un genere. Allora rilancio: la mente ha un genere? E poi il corpo. Il tuo romanzo è molto materico, pagina dopo pagina ho incontrato strade come vene, bene e male che si rincorrono e si mordono, corpi ammucchiati, corpi (anche quelli interi) costituiti da pezzi. Quanto influisce il genere, del corpo o della mente, sulla tua scrittura e a che livello ne è motore?

NV: Fare rete, per me, è il senso della vita: in quel senso la politica va intesa nel senso etimologico del termine. Politico è tutto ciò che riguarda il bene della comunità – e in questo momento direi che nessun governo è politico. Politico è il mio stare dentro la comunità cercando di far qualcosa di utile. Poi è utile anche l’intrattenimento. Per quello non ho mai potuto muovermi fuori dal genere (letterario). Leggere dev’esser bello per chi si avvicina a un libro, e una noiosa autoreferenzialità piace a ben pochi e solo se tu, come scrittore o scrittrice, sei un genio epocale, e di quelli ce ne son pochi. Perciò concordo: occorre che l’aspetto dell’intrattenimento ci sia, perché esso fa parte del rispetto del lettore. Un po’, era anche quello che diceva Beppe, quando insisteva, infuriandosi, che nella pittura la deriva concettuale è stata un imbroglio ai danni del pubblico. La sua pittura è sempre stata più narrativa: guardavo un quadro, e il mondo smetteva di esistere. Poi magari lui me lo spiegava anche, ma quello è un processo diverso. Questo voglio fare io (e, correggimi se sbaglio, ma mi pare che tu non dica cose diverse): io voglio arrivare al cuore subito, e ricostruire la ragione dopo. Va fatto anche quello, ma prima, prima devi arrivare al cuore, o alla pancia, o all’anima. Non so, chiamala come vuoi, ma quello è.
Il discorso del genere letterario e sessuale: sono davvero convinta che si scriva bene o male, indipendentemente da come è fatto il proprio corpo. Dopo di che, è proprio attraverso il corpo che si sperimenta il mondo, ed è indubbio che le donne – persino le donne che hanno una buona vita – consumano un’esperienza del mondo molto diversa da quella di un uomo. In qualunque forma d’arte questa diversità deve poter emergere, ma non è una differenza che si rifrange sulla quantità di doti che ha la scrittura. Semmai sulla qualità, ma non è neanche detto. Si scrive come si fa arte in qualsiasi ambito. Perché si è persone. E da persone si racconta il mondo filtrandolo attraverso i propri sensi.
Non è quello che fanno i tuoi personaggi in Cenere? Non c’è dubbio che Ash abbia un corpo che entra in modo prepotente, nella sua storia personale e nella vicenda collettiva del gruppo. Tu che ne pensi?
EE: In modo poco meditato, ovvero abbastanza naturale, le mie storie sono raccontate partendo dall’interno dei personaggi, che sono sfaccettature di me e di persone che ho conosciuto in modo intimo. In questo senso le dimensioni di comunità e di vicinanza con le persone entrano nelle mie storie. Nel caso di Ash, le sue competenze di chimica e il suo corpo, che è femminile e le dà la possibilità (o l’illusione) di poter proteggere suo padre e la sua missione. Questo può avere connessioni con quello che molte donne si trovano costrette ad affrontare nella vita reale.
 Concordo sul fatto che la scrittura sia buona o cattiva a prescindere dal genere dell’autore. Allora resta da vedere cosa s’intenda per buona scrittura. A me una storia fa innamorare quando trasmette emozioni, certo, e quando è disseminata di rimandi all’universale – quei passaggi che mi fanno staccare gli occhi dalla pagina e mi costringono a riassestare, anche molto in piccolo, il modo in cui io come persona vedo il mondo.
Concordo sul fatto che la scrittura sia buona o cattiva a prescindere dal genere dell’autore. Allora resta da vedere cosa s’intenda per buona scrittura. A me una storia fa innamorare quando trasmette emozioni, certo, e quando è disseminata di rimandi all’universale – quei passaggi che mi fanno staccare gli occhi dalla pagina e mi costringono a riassestare, anche molto in piccolo, il modo in cui io come persona vedo il mondo.
E poi l’arte che entra nella narrativa. Avrai i miei occhi mi ha preso davvero a partire dalla scena in cui Nikon mostra le sue foto a Nigredo, e le immagini si compongono nel collage di un corpo formato da pezzi diversi. Quel momento della tua storia mi ha suggerito un’interpretazione, una chiave di lettura, come la soluzione a un indovinello che ti chiarifica una dimensione di significato, non solo a livello di trama ma anche e soprattutto di valore.
Cambiando discorso: siamo due donne che scrivono (anche) fantascienza e abbiamo trovato casa (per me la prima, per te non proprio!) in Zona 42. Lo diresti uno spazio di libertà? Zona 42, la fantascienza e la scrittura?
NV: Anche per me scrivere è far venir fuori la storia dei personaggi, che è come se parlassero da soli, con la loro voce. Non saprei dire da dove arriva questa voce, se da me o da suggestioni del mondo. Nel mio caso, però, certi personaggi nascono da incontri casuali, durati un attimo, e che tuttavia mi hanno lasciato una traccia persistente. Questa traccia diventa storia. Non saprei dire come. Per intenderci: so bene da dove arriva Olivia, ma non ho idea di come sia nato Raul. Il Pittore è una persona vera, Ariel una combinazione di pezzi. E Nikon è lui e non può essere nessun altro. Si è fatto avanti sgomitando ed è entrato in scena senza permesso.
Che le donne debbano combattere è (purtroppo) un dato reale, che ne costruisce l’esperienza, nel bene e nel male, e in modi sottili. Non è che l’esito della battaglia sia sempre lieto. A volte si perde e basta, e si perde anche quando si ha l’impressione di aver vinto. Guadagnare il potere non è sempre una conquista. Secondo me, uno dei pregi della (buona) scrittura è la capacità di costruire una rappresentazione problematizzata, dove bene e male stanno, come scrivo, nello stesso guscio, ed è difficile separarli. Quel che trovo complicato è costruire la storia, e penso si veda. Quello è mestiere. Non mi viene naturale. Devo imparare, continuamente, ed è una cosa bella anche quella. Imparare, intendo. Però il problema con questa attitudine a imparare è che si cambia di continuo, si aggiusta il tiro, o si rettifica lo sguardo, come dici tu. E si mettono insieme i pezzi, come fa Nikon.
Non tanti editori riescono a stare appresso a questa cosa, a questo dinamismo continuo. Casa Zona lo fa. E mi pare una specie di miracolo. Zona 42 rappresenta per me il ritorno di un lavoro editoriale autentico. Piccolo, definito, attento. Come Jane Austen (fa ridere lo so): ragione e sentimento.
E perciò, domanda difficile: che posto ha il sentimento, nelle tue storie e nella tua vita editoriale?
 EE: Sentimento, eh? Nella mia vita editoriale si tratta principalmente di gratitudine. Non mi era mai capitato, prima di Zona 42, di avere qualcuno con cui confrontarmi, che mi guidasse senza giudicare e senza imporsi. Ti dicevo prima che ciò che voglio è scrivere buone storie, ebbene credo che sia con un confronto aperto che le storie migliorano e mi rendo conto di quanta fatica costi. Da qui la gratitudine: un libro è uno sforzo collettivo! Poi il terrore e l’adrenalina di inviare un manoscritto, perché la self-confidence non è proprio il mio forte e ogni volta è durissima uscire dal mio guscio. Nelle mie storie di solito è amore non corrisposto, o affetto da nascondere, o paura da controllare. Però è il sentimento, per quanto frustrato o forse proprio per questo, a muovere l’azione.
EE: Sentimento, eh? Nella mia vita editoriale si tratta principalmente di gratitudine. Non mi era mai capitato, prima di Zona 42, di avere qualcuno con cui confrontarmi, che mi guidasse senza giudicare e senza imporsi. Ti dicevo prima che ciò che voglio è scrivere buone storie, ebbene credo che sia con un confronto aperto che le storie migliorano e mi rendo conto di quanta fatica costi. Da qui la gratitudine: un libro è uno sforzo collettivo! Poi il terrore e l’adrenalina di inviare un manoscritto, perché la self-confidence non è proprio il mio forte e ogni volta è durissima uscire dal mio guscio. Nelle mie storie di solito è amore non corrisposto, o affetto da nascondere, o paura da controllare. Però è il sentimento, per quanto frustrato o forse proprio per questo, a muovere l’azione.
La costruzione della trama è problematica anche per me, però sto iniziando a prenderci gusto! Anche se il rischio diventa quello di ripetere il modello serie tv d’azione dove ogni puntata si conclude con un climax e dopo un po’ diventa una noia. Invece riguardo al tuo libro a colpirmi maggiormente è stato il linguaggio. Non mi stupisce che tu dia tanta importanza alle parole, perché si vede che le scegli con cura.
NV: A esporsi a un possibile fallimento non si impara mai, secondo me. Al massimo trovi strumenti e piccoli trucchi per non prenderti troppo sul serio, ma non è mai piacevole. E la scrittura tocca aspetti viscerali della nostra identità, dunque lì è ancora più doloroso essere rifiutati. Ho imparato a valutare i rifiuti per quel che sono: punti di vista, almeno se sono consapevole di aver fatto un lavoro serio.
Il fatto è che secondo me il linguaggio non è mai neutrale. Questa storia ha avuto più stesure, e ho faticato a trovare il tu come voce ideale. Dopo, è diventata l’unica voce possibile, il modo di Olivia di costruire un legame che lei percepisce molto bene e che invece Nigredo fatica a individuare. D’altra parte, gli uomini sono più lenti 😉
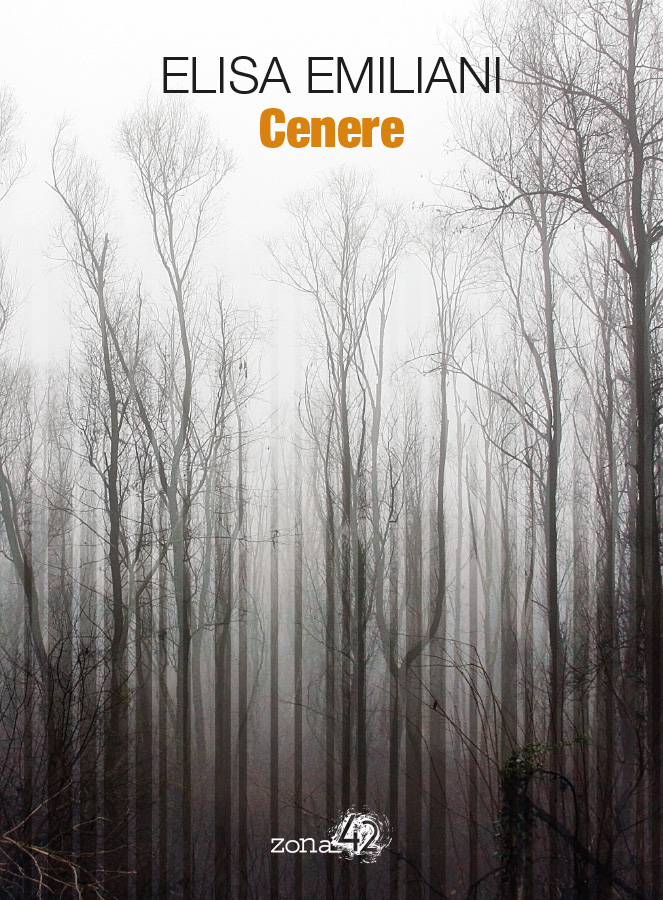
Dai, raccontami qualcosa anche dei tuoi personaggi maschili, che sono dei bei tipi anche loro. Dai giovani ai meno giovani.
EE: Dei personaggi maschili quello che mi piace è il padre di Ash, che è ispirato a mio nonno e alla sua officina. Sempre piena di roba ammucchiata in un ordine che lui capiva perfettamente. Ho provato a trasmettere un po’ di quel miscuglio folle di emozioni nel personaggio e nella relazione padre/figlia.
Che il linguaggio non sia mai neutrale è una grande verità, me ne sono accorta vivendo in Inghilterra, avevo una collega dello Sri Lanka che mi disse che in lingua Tamil non esiste una parola per dire anarchia! Adesso, a proposito di linguaggio, voglio scrivere la storia di un gruppo di ragazzi che si isola dagli altri e inselvatichisce, perdendo anche pezzi di linguaggio. Pensavo di scrivere pezzi in inglese e tradurre poi in italiano. Poi in spagnolo – che parlo peggio – e tradurre di nuovo in italiano. Verrà un pastrocchio e dovrò riscriverlo venti volte… E tu? A cosa lavori?
NV: Sì, in effetti la figura del padre di Ash è piaciuta moltissimo anche a me, e si capiva bene che vi fosse dietro un archetipo importante, ma ben declinato. E mi sembra una bella sfida quella che hai in mente. Sono già curiosa…
Non sto ancora lavorando a una cosa nuova. Vorrei costruire una sorta di trilogia di Milano, ma non ancora una idea chiara. Aspetto che il tempo mi porti, e di irrealtà ce n’è abbastanza in questo momento.
Vedremo. Per il momento, c’è una cosa che mi rende davvero ottimista: noi tutte, scrittrici di fantascienza italiana, stiamo cominciando a parlarci, e non succedeva da un sacco di tempo, dunque può solo portar bene.
…
(Questo dialogo tra Elisa Emiliani e Nicoletta Vallorani, curato da Angela Bernardoni è apparso in origine sulle pagine di Stay Nerd)
